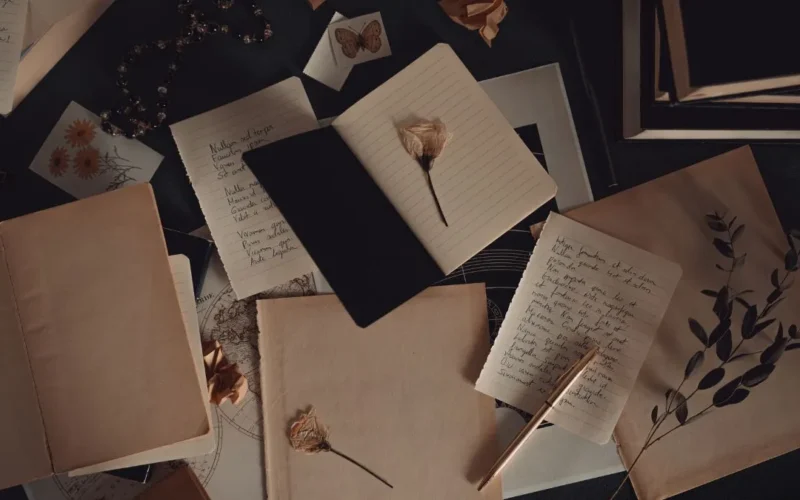(DI Yuleisy Cruz Lezcano)
Nel momento in cui una donna riesce finalmente a varcare la soglia di un centro antiviolenza, porta con sé non soltanto le ferite visibili che la violenza ha inflitto sul suo corpo, ma soprattutto quelle invisibili e profonde che hanno scavato nella sua identità, nelle sue relazioni, nella sua percezione del mondo. La violenza, sia essa fisica, psicologica, sessuale o economica, lascia un segno che non si cancella rapidamente e che spesso si manifesta attraverso modalità di comportamento che sfuggono persino alla comprensione della stessa vittima. Per questo, nei centri antiviolenza e nei percorsi terapeutici, la prima tappa fondamentale è la costruzione della consapevolezza: comprendere che ciò che si è vissuto non è normale, non è inevitabile e soprattutto non è colpa propria.
La ricerca scientifica internazionale, a partire dagli studi pionieristici delle due studiose statunitensi Ann Wolbert Burgess e Lynda Lytle Holmström negli anni Settanta, ha mostrato come la violenza, in particolare quella sessuale, generi una complessa sindrome da trauma da stupro. Questa condizione, descritta allora come una sequenza di fasi emotive e comportamentali, include reazioni immediate di disorientamento, paura, vergogna e shock, seguite spesso da un periodo molto lungo in cui la vittima tenta di riconquistare un equilibrio apparente. Molte donne, in questa fase, modificano radicalmente le loro abitudini: cambiano casa, città, lavoro; allontanano amicizie o legami di famiglia; adottano comportamenti iper-vigili o, al contrario, tentano di cancellare ciò che è accaduto relegandolo in un silenzio interiore che può durare anni. La ricerca più attuale ha dimostrato che queste reazioni non sono segni di debolezza, bensì risposte fisiologiche e psicologiche a un evento traumatico che ha messo in pericolo la vita, l’integrità e la dignità della persona.
Accanto alla sofferenza psicologica, numerosi studi sociologici hanno evidenziato come la violenza produca anche un profondo isolamento sociale. La società spesso fatica a dare un nome alle cose: minimizza, giustifica, mette in discussione la parola della donna, alimentando quella spirale di colpa e vergogna che rende così difficile chiedere aiuto. La vittima si trova così a convivere con un doppio silenzio: quello interno, fatto di pensieri confusi e dolorosi, e quello esterno, fatto di incomprensioni, giudizi e solitudine. È proprio in questo punto fragile e delicato che intervengono gli operatori e le operatrici dei centri antiviolenza, che accolgono la donna accompagnandola non solo nella protezione fisica, ma anche in un percorso che la aiuti a riconoscere la violenza subita come tale, a comprenderne gli effetti sulla mente e sul corpo, e a diventare parte attiva della propria rinascita.
Molte vittime, secondo gli studi psicologici più recenti, si trovano inizialmente incapaci di riconoscere come violenti comportamenti che, con il tempo, erano diventati parte della routine quotidiana. Le minacce, le umiliazioni, il controllo economico, l’isolamento dai rapporti familiari e amicali, la manipolazione emotiva: tutto questo, nel contesto di una relazione abusante, può apparire confuso, normale o addirittura inevitabile. Ma è attraverso la parola, la narrazione, la ricostruzione dei fatti, il racconto condiviso con altre donne o con una figura professionale, che qualcosa comincia a cambiare. La narrazione è uno degli strumenti terapeutici più potenti: permette di rimettere ordine nel disordine, di riconoscere la violenza e chiamarla per nome, di attribuire responsabilità all’aggressore e non a sé stesse. La presa di coscienza è il primo passo per uscire dallo stato di vittima passiva e diventare protagonista del proprio processo di guarigione.
Nell’ambito terapeutico, negli ultimi anni, si sono diffuse con crescente efficacia pratiche integrate che combinano la ricostruzione cognitiva del trauma con attività creative e corporee. Un esempio significativo è il Progetto TAMAR, acronimo che indica un percorso su gravi traumi, dipendenze, salute mentale e recupero. Sviluppato inizialmente negli Stati Uniti all’interno di istituzioni pubbliche, il progetto si basa su un approccio didattico e terapeutico strutturato che unisce conoscenze sul trauma, educazione psicologica e modalità espressive. Il cuore del programma è semplice ma rivoluzionario: le persone che hanno vissuto traumi complessi non hanno soltanto bisogno di parlare di ciò che è accaduto, ma anche di trovare linguaggi alternativi che permettano di esprimere il dolore quando le parole non bastano o feriscono.
Il Progetto TAMAR utilizza quindi strumenti creativi come il disegno, la scrittura autobiografica, la narrazione collettiva, il lavoro simbolico e altre forme di espressione artistica, affinché chi ha subito violenze possa rielaborare il trauma senza esserne sopraffatto. Attraverso la creatività, molte donne riescono a raccontare per la prima volta ciò che non hanno mai potuto dire. Il gesto di tracciare una linea su un foglio, di scegliere un colore, di mettere in scena un frammento della propria storia con il supporto di un gruppo, diventa un modo per restituire un senso al disordine interiore e ricostruire la propria identità. L’espressione creativa non è un dettaglio marginale: è una porta attraverso cui si possono affrontare emozioni che non trovano spazio nel linguaggio razionale, è un atto di libertà dopo anni di controllo e costrizione.
Gli operatori dei centri antiviolenza conoscono bene l’importanza di questi strumenti. Sanno che la guarigione non avviene solo attraverso la protezione dalle minacce o attraverso i percorsi legali, ma anche, e soprattutto, attraverso un lento lavoro sulla consapevolezza, sulla dignità, sull’autostima. Sanno che per molte donne il trauma non è un evento chiuso nel passato, ma una ferita ancora aperta che continua a influenzare le scelte, le relazioni e la percezione di sé. E sanno che ogni percorso è unico: c’è chi necessita di ascolto, chi di protezione immediata, chi di percorsi di gruppo, chi di interventi individuali specialistici, chi di sostegno economico o legale, chi di un luogo sicuro in cui poter respirare senza paura.
La sfida dei percorsi post-violenza è grande e complessa. Ma grazie agli avanzamenti della ricerca psicologica e sociale, ai programmi educativi strutturati come il Progetto TAMAR e al lavoro quotidiano di chi opera nei centri antiviolenza, oggi è possibile offrire alle sopravvissute non solo un sostegno, ma una reale prospettiva di trasformazione personale. Uscire dalla violenza è un atto di enorme coraggio, ma non è un cammino che si possa fare da sole. È un percorso che richiede ascolto, competenza, presenza costante, conoscenza del trauma e grande rispetto per i tempi e le scelte della donna.
Quando la consapevolezza inizia a emergere, quando la donna comprende che ciò che ha vissuto non la definisce, ma può diventare parte di una storia più grande di rinascita, allora il processo di guarigione si avvia. E in quel momento, nella faticosa consapevolezza del trauma e nella scoperta di nuove risorse interiori, la vittima non è più soltanto tale: diventa una sopravvissuta che ricostruisce la propria vita, passo dopo passo, con la forza che nessuna violenza potrà mai cancellare.